> FocusUnimore > numero 55 – febbraio 2025
The relationship between melanoma and solar radiation, pollution and night-time light as causes of childhood leukaemia, and prostate cancer metabolism: these are the themes of the projects funded for the Life Sciences sector (FOMO Line).
The research projects funded by Unimore through the FAR 2024 call for the ERC Life Sciences sector consist of three studies, each receiving a grant of €73,600. The first project, led by Prof. Alberto Modenese, focuses on the relationship between skin melanoma and exposure to ultraviolet solar radiation at work in the Modena area, aiming to promote the prevention of occupational diseases related to solar radiation. The second project, led by Prof. Marcella Malavolti, investigates the environmental risk factors, such as air pollution and night-time light, associated with childhood leukaemia risk in the Modena population. The third project, led by Prof. Silvia Belluti, is dedicated to lactate metabolism in prostate cancer, with the goal of identifying therapeutic vulnerabilities and diagnostic biomarkers. These interdisciplinary studies aim to improve prevention, diagnosis, and treatment of diseases linked to environmental and oncological factors.
I progetti di ricerca finanziati da Unimore attraverso il bando FAR – Fondo di Ateneo per la Ricerca 2024 – Linea FOMO (Fondazione di Modena) per il Macrosettore ERC di Scienze della Vita – LS sono tre, ognuno dei quali ha ricevuto un finanziamento di 73.600 euro.
Due di questi studi sono coordinati da docenti del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze (BMN): il progetto “Melanoma of the skin and exposure to solar ultraviolet radiation at work in Modena territory: a casecontrol study to promote an active search and prevention of occupational diseases based on recent INAIL criteria” (Melanoma cutaneo ed esposizione a radiazioni solari ultraviolette sul lavoro nel territorio modenese: uno studio di casocontrollo per promuovere una ricerca attiva e una prevenzione delle malattie professionali basata sui recenti criteri INAIL) coordinato dal Prof. Alberto Modenese e il progetto “Air pollution, light at night and greenness as risk factors of childhood leukemia: a study in the Modena population, Northern Italy” (Inquinamento atmosferico, luce notturna e verde urbano come fattori di rischio di leucemia infantile: uno studio nella popolazione di Modena) coordinato dalla Prof.ssa Marcella Malavolti.
L’altro progetto di ricerca “Transcriptional reprogramming of lactate metabolism in prostate cancer: druggable vulnerabilities for therapeutic and diagnostic applications” (Riprogrammazione trascrizionale del metabolismo del lattato nel cancro alla prostata: vulnerabilità farmacologiche per applicazioni terapeutiche e diagnostiche) è coordinato dalla Prof.ssa Silvia Belluti del Dipartimento di Scienze della Vita.
Il progetto, che ha come PI il Prof. Alberto Modenese e come co-proponenti la Prof.ssa Paola Ferri e il Prof. Sergio Rovesti anche loro del Dipartimento BMN e la Prof.ssa Francesca Farnetani del Dipartimento CHIMOMO, ha lo scopo di valutare, in uno studio caso-controllo, le relazioni tra lavoro all’aperto e neoplasie cutanee in pazienti dermatologici dell’AOU di Modena.
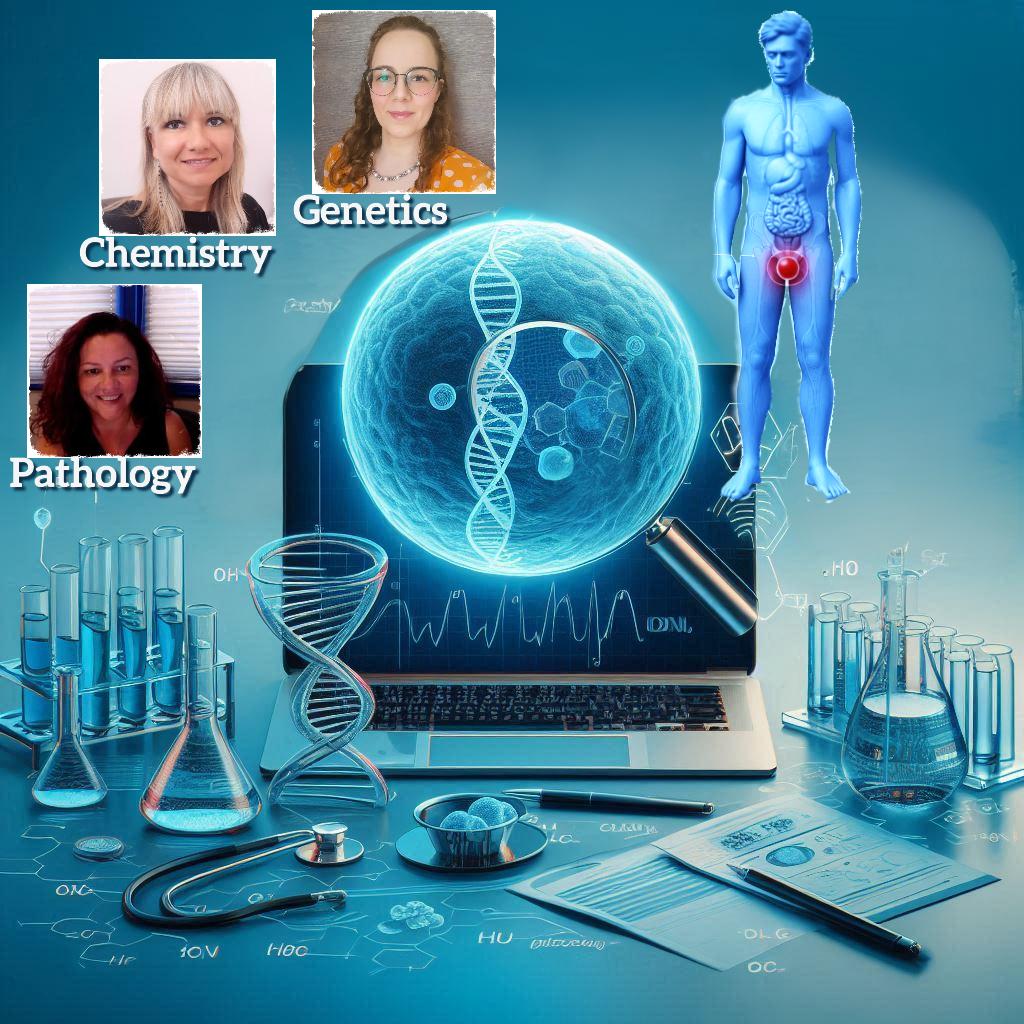
I partecipanti sono intervistati per la raccolta di informazioni sulle specifiche tipologie istologiche e localizzazioni delle neoplasie diagnosticate e sulla presenza dei principali fattori di rischio occupazionali e non-occupazionali. I pazienti con storia di lavoro all’aperto sono assegnati a categorie crescenti d’esposizione a radiazione solare, onde verificare con analisi mirate le associazioni tra i livelli espositivi e le specifiche forme neoplastiche, e identificare possibili patologie professionali.
“In ultima analisi – dichiara il Prof. Alberto Modenese – lo studio che stiamo conducendo mira a far emergere, nel nostro territorio, come prima esperienza italiana di questo tipo, un fenomeno largamente misconosciuto, ma ampiamente diffuso: quello dei tumori cutanei professionali da radiazione solare. In particolare, riferendoci al melanoma, questo non era indicato tra le malattie a sospetta eziologia professionale nel nostro Paese prima della pubblicazione di una recente monografia INAIL, che peraltro riprende e cita la metodologia di un nostro articolo pubblicato nel 2019. Una maggior attenzione e consapevolezza pubblica e istituzionale a problematiche di salute, ottenuta anche con la segnalazione dei casi, è un tassello fondamentale onde poter stimolare l’implementazione delle necessarie misure di prevenzione”.
“Voglio ringraziare il nostro Ateneo e la Fondazione di Modena per aver valutato positivamente il progetto ed averci fornito un indispensabile supporto – prosegue il Prof. Modenese -. Ringrazio l’intero gruppo di ricerca ed i nostri Dipartimenti per la fondamentale collaborazione interdisciplinare che ha portato al successo di questa proposta. La tematica affrontata è certamente di grande impatto per la popolazione del nostro territorio, in ragione delle sue caratteristiche occupazionali, geografiche e demografiche, ed anche alla luce delle nuove sfide e dei cambiamenti posti in essere dai mutamenti climatici in atto”.
Lo studio coordinato dalla Prof.ssa Marcella Malavolti vuole invece valutare l’associazione tra l’esposizione a fattori di rischio ambientali e il rischio di leucemia infantile con particolare riferimento a: benzene e altri inquinanti contenuti nelle emissioni del traffico autoveicolare, inquinanti, verde urbano, luce notturna artificiale.
Si tratterà di uno studio caso-controllo retrospettivo di popolazione. Lo studio prevede l’individuazione, in stretta collaborazione con i medici della Struttura Complessa di Pediatria ad Indirizzo Oncoematologico del Dipartimento Materno-Infantile del Policlinico di Modena (Dott. Giovanni Palazzi), col Registro nazionale AIEOP e con il Registro Nazionale AIRTUM, di tutti i casi di leucemie diagnosticati a partire dal 1998 e sino al 2022 in bambini di età inferiore o uguale ai 14 anni, residenti al momento della diagnosi nel territorio principale di afferenza di tale struttura, la provincia di Modena.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, saranno effettuate delle simulazioni modellistiche della dispersione delle emissioni di benzene e altri inquinanti emessi da traffico autoveicolare sull’intero territorio analizzato al fine di stimare l’esposizione all’indirizzo di residenza dei bambini. Tale determinazione delle aree espositive verrà effettuata dai ricercatori del Centro di Ricerca LARMA del Dipartimenti di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Prof. Sergio Teggi, Ing. Sofia Costanzini e Ing. Nicolò Martini).
Per quanto riguarda il verde e gli spazi verdi urbani, saranno valutati tramite l’uso di immagini satellitari quali quelle disponibili tramite i sensori multispettrali della missione Sentinel 2 focalizzati sul monitoraggio della copertura del suolo e dati vettoriali ausiliari. Per questo progetto, utilizzeremo in particolare il Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), che è l’indice più utilizzato al mondo per stimare la biomassa vegetata, a cui verranno aggiunte le mappe di uso del suolo sopracitate al fine di caratterizzare la tipologia di verde.
Per misurare l’esposizione alla luce notturna verranno utilizzate immagini di telerilevamento dai sensori Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) a bordo dei satelliti congiunti NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP, lanciato nel 2011) e NOAA-20 (lanciato nel 2017), disponibili gratuitamente dal Payne Institute della Colorado School of Mine, sezione Earth Observation Group (https://eogdata.mines.edu/products/vnl/ ) che sviluppa mappe globali della luce notturna: giornaliere, mensili e annuali.
I risultati attesi dal nostro studio sono di individuare e quantificare eventuali modifiche del rischio di leucemie infantili associabili all’esposizione ai tali fattori di rischio ambientali, nonché possibili fattori protettivi per esposizione al verde urbano, sia presi singolarmente che nel loro complesso all’interno di un modello che valuti la loro interazione.
“Per noi ricercatori individuare le cause che conducono all’insorgenza di un tumore in età pediatrica è complicato e non sempre possibile – commenta laProf.ssa Marcella Malavolti –. Le cause possono essere radicate nel Dna fin dalla nascita oppure essere condizionate dall’effetto dell’ambiente sul nostro codice genetico. Dare le giuste proporzioni è arduo. Sicuramente non tutti i casi di leucemia dipendono dall’esposizione agli inquinanti ambientali, ma il mondo scientifico sta provando a identificare i possibili co-responsabili”.
La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d’età da 0 a 14 anni e di 800 in quella dai 15 ai 19 anni (AIRTUM, l’Associazione Italiana Registri Tumori). I bambini e i ragazzi tra 0 e 19 anni che muoiono di tumore sono sempre meno: nel 2008 i decessi erano circa un terzo di quelli registrati nei primi anni Settanta, e oggi oltre l’80 per cento dei pazienti guarisce. I bambini sono più suscettibili agli agenti ambientali per due ragioni. In presenza di condizioni di inquinamento identiche, registrano livelli di esposizione più alti per tutte le sostanze. Ci sono poi diversi aspetti fisiologici e legati allo sviluppo, che li rendono più vulnerabili agli effetti tossici degli inquinanti ambientali. Rispetto agli adulti, i bambini hanno bisogno di una maggiore quantità di energia per la crescita e lo sviluppo, che si traduce in una più elevata assunzione di ossigeno e cibo per chilogrammo di peso corporeo. Questi due aspetti possono determinare esposizioni più alte, per inalazione e ingestione, a contaminanti presenti nell’aria e negli alimenti.
“È difficile sbilanciarsi, con i dati attualmente a disposizione. Bisogna però suggerire un maggior approccio precauzionale nei confronti di questa popolazione, proteggendola di più dall’esposizione ai gas di scarico, provenienti dai motori diesel e benzina, e al fumo passivo di tabacco. A noi ricercatori, invece, spetta di potenziare le indagini epidemiologiche, se si vuole trovare una risposta univoca che spieghi gli eccessi evidenziati” – prosegue la Prof.ssa Malavolti.
La ricerca interdisciplinare guidata dalla Dott.ssa Silvia Belluti è dedicata in primis allo studio dei meccanismi molecolari che regolano il metabolismo delle cellule tumorali, contribuendo ai processi di progressione e metastatizzazione del cancro alla prostata. L’obiettivo della ricerca è quello di ampliare le conoscenze su questo tumore e di sviluppare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici per migliorare la gestione clinica del tumore prostatico.
La Dott.ssa Silvia Belluti, ricercatrice del laboratorio di Genetica Molecolare del Dip. Scienze della Vita, ha recentemente dimostrato come il fattore di trascrizione NF-Y abbia un ruolo cruciale nei meccanismi molecolari che determinano la progressione del cancro alla prostata. Per approfondire questo aspetto, lo studio analizzerà come l’espressione di NF-Y influisca sul metabolismo del lattato e sulla capacità metastatica delle cellule tumorali, utilizzando modelli in vitro con livelli di NF-Y modulati in laboratorio. Il team valuterà le alterazioni metaboliche, genetiche e cellulari in condizioni sperimentali che riproducono l’ambiente complesso del tumore per identificare nuovi possibili target terapeutici.
Un secondo obiettivo chiave della ricerca è l’identificazione di nuovi biomarcatori per una diagnosi più precisa. Gli strumenti diagnostici attuali purtroppo non sempre distinguono le forme più aggressive del tumore della prostata. Grazie a moderne tecnologie di proteomica e alla collaborazione con il laboratorio di patologia clinica guidato dalla Dott.ssa Stefania Bergamini del Dip. Chimomo, il team cercherà nuovi biomarcatori legati a NF-Y e al metabolismo del lattato, per consentire una migliore classificazione dei pazienti e rendere le terapie più mirate ed efficaci.
Inoltre, il progetto consentirà di sintetizzare nuove molecole per applicazioni diagnostiche e terapeutiche. Poiché il metabolismo del lattato è essenziale per la sopravvivenza delle cellule tumorali, il gruppo di chimici guidato dalla Prof.ssa Erika Ferrari del Dip. Scienze Chimiche e Geologiche lavorerà alla sintesi di inibitori della proteina MCT1, il principale trasportatore del lattato, con potenzialità terapeutiche e diagnostiche. Sfruttando approcci innovativi di radiomarcatura, il gruppo interdisciplinare esplorerà strategie che combinano diagnosi e terapia, con la prospettiva di arrivare ad una diagnosi migliore e allo sviluppo di una possibile terapia personalizzata.
“Grazie al supporto dell’Ateneo e della Fondazione di Modena, per i progetti presentati da ricercatori under 40, questo studio rappresenta un’importante opportunità per il mio consolidamento come giovane ricercatrice all’interno dell’Ateneo – commenta la Dott.ssa Silvia Belluti –. Inoltre, il progetto consentirà di formare un nuovo gruppo di lavoro con una leadership tutta al femminile, all’interno del quale saranno reclutati due giovani ricercatori che avranno l’opportunità di operare in un ambiente interdisciplinare e stimolante. Questa ricerca risponde all’urgenza di migliorare la diagnosi e il trattamento del cancro alla prostata, il tumore più comune tra gli uomini in Italia, dove si stima che siano stati diagnosticati 41.100 nuovi casi nel 2023. Secondo i dati più recenti del Registro Tumori dell’Emilia Romagna, anche la nostra regione non fa eccezione e la provincia di Modena si colloca al terzo posto in regione per incidenza del tumore alla prostata. Per questo motivo – prosegue la Dott.ssa Belluti -, il nostro impegno mira ad un impatto concreto sulla salute delle persone. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la diagnosi e sviluppare strategie terapeutiche efficaci, con ricadute significative sulla qualità della vita dei pazienti con tumore della prostata. Questo progetto rappresenta un’opportunità per far avanzare la ricerca scientifica, creare e consolidare collaborazioni lavorative e formare giovani ricercatori, contribuendo alla crescita della comunità scientifica locale e internazionale. Grazie al sostegno ricevuto, possiamo guardare al futuro con fiducia, puntando a scoperte che possano davvero fare la differenza nella lotta contro il cancro alla prostata”.
