> FocusUnimore > numero 9 – novembre 2020
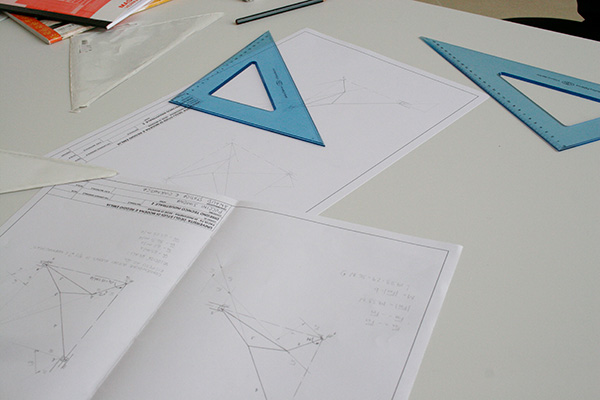
“Dottorato” questo sconosciuto si poteva dire fino a qualche tempo fa. Oggi, fortunatamente grazie ad alcuni interventi legislativi e normativi piuttosto recenti succedutisi nell’ultimo ventennio a partire dal DM 30 aprile 1999, n. 224 “Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca” (G.U. n. 162 del 13/07/99) e con atti successivi intensificatisi a partire dal 2013, il “Dottorato”, che costituisce l’apice della formazione universitaria, è diventato una realtà significativa nel mondo accademico, una realtà che comincia a godere dello stesso prestigio che il cosiddetto “PhD”, il titolo che si consegue al termine di questo percorso triennale per il quale è stato introdotto un accreditamento da parte del MUR, ha a livello internazionale. Sullo stato dei “Dottorati” in Italia, sulla loro finalità e sui “Dottorati industriali” ne parliamo col Prof. Paolo Pavan, Delegato del Rettore per la Ricerca.
Parlare di dottorato come una realtà unica è certamente complesso. A Modena e Reggio Emilia, giusto per parlare del nostro ateneo, sono presenti 15 corsi di dottorato di ambiti disciplinari diversi, su tematiche differenti e con diversi modi di fare ricerca. È possibile però individuare un elemento che li accomuna o sono realtà non paragonabili?
Io credo che qualcosa in comune ci sia e che sia stato dettato anche dalle modifiche di legge che sono intervenute negli ultimi anni. Oggi i dottorati sono più strutturati: in tutti i dottorati c’è un minimo di requisiti da rispettare, ovviamente flessibile e adattabile ai mondi della ricerca a cui si riferiscono introdotti per accrescere il valore ed il prestigio di questo titolo di terzo livello a standard internazionali. Credo che questo abbia avuto un impatto positivo sulla figura del dottorando e sull’immagine del dottorato, sia all’interno del mondo accademico, che nel suo apprezzamento all’esterno dell’università.
In che senso questa strutturazione ha avuto un impatto all’interno del mondo accademico?
Fino a non molto tempo fa c’era una grossa diversità tra un dottorando e l’altro, derivante in primo luogo dal “tutor”. L’identificazione tra dottorando e tutor era alta se non addirittura totale, tanto che il dottorando era chiamato “l’assistente” del professore. Il professore tutor in larga misura replicava il suo modello di ricerca sui dottorandi di cui era responsabile. In molti casi andava bene, in molti altri meno. La strutturazione dei percorsi di dottorato ha contribuito ad emancipare la figura del dottorando dalla figura dell’assistente: il tutor rimane importante, ma l’impalcatura comune che si è costruita permette a tutti di avere una base comune in termini di offerta formativa ed esperienze di ricerca.
Ma tutto questo non ha come contropartita una sorta di standardizzazione delle conoscenze e dell’offerta formativa? Il rischio non è quello di contribuire all’omologazione dei saperi e del modo di fare ricerca? Inoltre, un effetto di questa strutturazione, non rischia di posticipare il momento della ricerca ad una fase post-doc?
No, non credo che questo c’entri con la strutturazione del dottorato. Il fatto che venga proposta anche una preparazione al mondo della ricerca e che si chiedano dei prodotti di ricerca è una garanzia di fare di questo percorso una esperienza di ricerca scientifica. Ancora, avere due revisori esterni al collegio proietta in una vera dimensione di ricerca interaccademica, consente al dottorando di aprirsi ad un’altra dimensione della ricerca che non sia solo quella del proprio ateneo, obbliga a presentarsi alla propria comunità scientifica, una comunità più ampia e non ristretta alla sede e alle sue relazioni storiche. La ricerca funziona ed è fatta bene se ci si confronta con la propria comunità. È ovvio poi che ci sono diversità tra diversi ambiti di ricerca, discipline, ecc … però pur nel rispetto delle diversità è necessario che i dottorandi si aprano alla loro comunità scientifiche di riferimento: pubblicare su riviste, scrivere dei testi scientifici, partecipare a progetti e confrontarsi alla pari con un mondo che ha gli strumenti per capire e valutare quello che stai facendo. Ci sono certamente differenze tra discipline. Le discipline non bibliometriche, ad esempio, presentano peculiarità che è giusto tenere in considerazione, ma rimane il fatto che ti devi confrontare, devi comunque avere un’interlocuzione ed è meglio se questa interlocuzione è ampia e internazionale: il dottorato deve avere anche l’obiettivo di dare gli strumenti per crearla.
E per quel che riguarda la percezione del dottorato all’esterno dell’Università? In che senso, come accennavi in precedenza, il processo di strutturazione del dottorato ha avuto un impatto positivo?
Anni fa il dottorato era percepito semplicemente come il prerequisito per fare carriera accademica, ed era un oggetto oscuro al di fuori del mondo universitario. Prima un dottore di ricerca veniva visto come un “neo-laureato con più pretese” che cerca lavoro in un’impresa ma che avrebbe preferito l’accademia, mentre ora non è più così. Avendo perso quest’aurea di prodromo della carriera accademica, il dottorato ha cominciato ad essere percepito diversamente anche all’esterno dell’università. Anche grazie alla sua progressiva strutturazione il dottorato oggi si è reso riconoscibile come un titolo di studio a tutti gli effetti. La figura del dottore di ricerca si pone sul mercato con delle caratteristiche che sono un po’ più uniformi, grazie alla previsione di specifici criteri di accreditamento introdotti a seguito del DM 8 febbraio 2013, n. 45, e che permette agli attori del territorio, in primis alle imprese, di riconoscere una categoria di persone che prima facevano fatica a inquadrare.
Credi quindi che la percezione del dottore di ricerca all’esterno del mondo accademico sia cambiata fino ad essere considerata una figura che fa ricerca e che può dare un valore aggiunto? E ha la percezione che il nostro territorio e il rispettivo tessuto produttivo abbia la stessa percezione di cui tu parli?
Beh, ci sono ancora problemi, a cominciare dal differenziale di stipendio. Negli USA il PhD fa la differenza in questo senso rispetto al master o al bachelor. Da noi non è ancora così, anzi in molte realtà il dottorato è ancora considerato un aggravio di istruzione. Le aziende più innovative e dinamiche cominciano però a fare propria l’idea che l’impresa si possa dotare di figure che sanno fare ricerca autonomamente e che possono e sappiano lavorare con una rete di ricerca. C’è però un problema strutturale italiano legato alla dimensione delle aziende. Nel nord est in particolare è presente un tessuto produttivo di piccole e medie imprese che fanno fatica a fare questo salto. L’azienda piccola o media spesso mette insieme, ad esempio, l’ufficio ricerca e sviluppo con l’ufficio tecnico, che pure sono due cose diverse, due mondi diversi. Le piccole imprese fanno fatica a permettersi di non accorpare i due uffici, perché la loro dimensione porta a fare una scelta di questo tipo. Anche nel nostro territorio solo le imprese più forti e grandi possono permettersi di fare ricerca.
Questo evidentemente è un elemento di criticità per gli sbocchi occupazionali di chi fa un dottorato. Sembra che noi stiamo fornendo dottori di ricerca per l’Europa. Niente di male se a questo flusso corrispondesse anche il flusso contrario. Ma questo flusso contrario esiste?
In generale è vero che noi formiamo dottori di ricerca anche per l’Europa, cosa che non è da leggere negativamente in quanto dimostra che la preparazione raggiunta dai nostri dottori ne fa delle figure apprezzate e stimate, ma quello che va denunciato è che in Italia non stiamo perseguendo una politica che consenta di assorbirli e valorizzarli tutti: la differenza di stipendio è micidiale questo spiega perché tanti sono attratti dalla idea di andarsene. Detto questo, l’Emilia-Romagna con Art-ER e le università della Regione hanno appena presentato un dottorato europeo, un progetto governativo regionale per cominciare a diventare attrattivi e per cominciare ad inserire dottori di ricerca provenienti dall’Europa nei quattro atenei e nel tessuto produttivo. La domanda è stata presentata, se il progetto verrà approvato più di 50 persone saranno reclutate nei prossimi anni e verranno qui a vivere da dottorandi, con una borsa di studio europea. Questo progetto “FutureData4EU” vuole contribuire a creare in Emilia-Romagna un contesto di ricerca internazionale dove aziende e Università si incontrano e collaborano attraverso il dottorato.
E per quel che riguarda il settore pubblico? Ci sono differenze?
A prescindere dai casi specifici, in generale il pubblico fa più fatica a riconoscere il valore di un dottorato, c’è una dimensione culturale e probabilmente anche normativa che andrebbe aggiornata. Allo stesso tempo si vede bene quando uno ha fatto un dottorato. Prendiamo ad esempio l’ufficio ricerca qui in ateneo: in genere, il personale con il titolo di dottore di ricerca riesce a partecipare in modo attivo alla progettazione di progetti internazionali. I risultati si vedono, perché da pochi progetti europei di qualche anno fa siamo passati ad averne 99 attivi; proprio in questi giorni sta entrando il centesimo! Il contributo di chi ha un PhD sta dando i suoi frutti, poiché il personale ha e gestisce relazioni nazionali e internazionali, sa preparare un progetto scientifico, confrontarsi in una comunità scientifica … queste sono competenze che si acquisiscono sul campo, facendole durante il dottorato, non si imparano sui libri.
C’è un punto che non abbiamo toccato: i dottorati industriali. Ritieni che questa nuova tipologia di dottorato abbia contribuito a cambiare la percezione del dottorato al di fuori dell’università?
Il dottorato industriale, tipologia introdotta dalla recente normativa, sta ancora crescendo e deve ancora trovare la sua identità precisa per vari motivi, compresi gli interessi diversi che convergono su questa figura. Altri paesi hanno una lunga tradizione del dottorato industriale e i risultati sono molto positivi. Da noi invece a volte se ne distorce il senso che, in ultima istanza, è quello che un’azienda decide di investire sulla formazione di un suo dipendente e lo fa attraverso la formazione di alto livello che l’università offre. È ovvio che un dottorato industriale non è uguale ad un dottorato a tempo pieno in università, ma non può risolversi nella situazione in cui la ricerca che il dottorando/dipendente è tenuto a svolgere risulti marginale. Nelle università serie i dottorandi industriali vengono bloccati subito se non ottengono risultati di ricerca: questa è la direzione cui dobbiamo tendere. Credo però che il dottorato industriale sia impostato in modo interessante e che, se utilizzato bene, sia coerente con il ruolo che l’università dovrebbe avere e rappresenti un’ulteriore risorsa sia per l’università, che per il mondo con cui l’università si interfaccia.
In che senso?
Credo che l’università debba avere un ruolo anche etico: far capire al mondo esterno cosa significa fare ricerca e cosa significhi innovazione. Ogni meccanismo che permetta questa trasmissione di conoscenza e questa contaminazione è utile e il dottorato industriale può svolgere questa funzione. Per fare questo però l’università non deve uscire da una dimensione etica e la sua autorità deve continuare ad essere riconosciuta perché basata su competenze reali e solide. In questo senso non mi piace sentire dire che “l’università deve rispondere al territorio”. No, perché se, estremizzando, ti poni come un attore che reagisce alle sollecitazioni o alle richieste esplicite del territorio non sei più università. L’università deve essere in grado di proporre al tessuto economico e sociale, non semplicemente di rispondere. L’università deve proporre e anticipare la necessità di innovazione e cambiamento del territorio se non vuole andare al traino delle esigenze contingenti: è questo il nostro compito. L’università dovrebbe essere il motore dell’innovazione e cominciare ad avere percorsi strutturati, come quello del dottorato di cui abbiamo appena parlato, e stabilire regole di relazione che permettono a tutti gli attori, università e imprese o enti locali, di conoscersi, rispettarsi, apprezzarsi per le diversità e contribuire tutti al benessere collettivo.
